2000 - Convegno al CNEL
Dimensione: 94,68 KB
25 gennaio 2000 - CNEL
Responsabilità e risorse si vanno spostando dal livello centrale dello Stato a quello dei soggetti territoriali. Ciò richiede la modificazione dell'organizzazione dei diversi soggetti, appartenenti sia all'area pubblica che privata, ma richiede altresì l'organizzazione della loro integrazione a favore di una nuova realtà a cui dare identità: il territorio!
La formazione-intervento è stata applicata finora per il miglioramento delle organizzazioni di diversa natura operando sull'integrazione di funzioni diverse, sull'empowerment e sulla partecipazione e sull'apprendimento della comunità sia interna che del contesto di riferimento.
Oggi essa può essere usata anche nei processi di integrazione tra enti diversi che operano sullo stesso territorio e che pur espletando funzioni diverse, operano tutti all'interno della stessa organizzazione/territorio e a favore dello stesso cliente: il cittadino!
Il territorio può dunque essere inteso come un'Organizzazione multicentrica che va assecondata nella sua crescita e continua trasformazione.
La formazione-intervento è una metodologia partecipativa che serve a coinvolgere le persone di un'Organizzazione consentendo loro di ripensare e riorganizzare il proprio assetto e funzionamento organizzativo così da aumentarne l'efficienza e l'efficacia, migliorando contemporaneamente la qualità della vita di lavoro che la contraddistingue.
Per l'Organizzazione/Territorio l'obiettivo della sua applicazione può essere quello di consentire la revisione condivisa e partecipata delle condizioni che caratterizzano la sua attrattività sul piano degli investimenti infrastrutturali e produttivi e la conseguente e positiva ricaduta sul piano dell'occupazione e del benessere economico della comunità che vi risiede, migliorando nel contempo la qualità della vita e dell'ambiente.
L'Istituto di Ricerca per la Formazione-Intervento ha promosso questo convegno per discutere con amministratori pubblici, imprenditori, manager, sindacalisti, consulenti, studiosi, delle necessità che si avvertono a livello territoriale, dell'uso che si può fare della metodologia della formazione-intervento al riguardo e delle trasformazioni necessarie al sistema di regole vigenti così da consentirne l'uso.
La formazione-intervento è stata applicata finora per il miglioramento delle organizzazioni di diversa natura operando sull'integrazione di funzioni diverse, sull'empowerment e sulla partecipazione e sull'apprendimento della comunità sia interna che del contesto di riferimento.
Oggi essa può essere usata anche nei processi di integrazione tra enti diversi che operano sullo stesso territorio e che pur espletando funzioni diverse, operano tutti all'interno della stessa organizzazione/territorio e a favore dello stesso cliente: il cittadino!
Il territorio può dunque essere inteso come un'Organizzazione multicentrica che va assecondata nella sua crescita e continua trasformazione.
La formazione-intervento è una metodologia partecipativa che serve a coinvolgere le persone di un'Organizzazione consentendo loro di ripensare e riorganizzare il proprio assetto e funzionamento organizzativo così da aumentarne l'efficienza e l'efficacia, migliorando contemporaneamente la qualità della vita di lavoro che la contraddistingue.
Per l'Organizzazione/Territorio l'obiettivo della sua applicazione può essere quello di consentire la revisione condivisa e partecipata delle condizioni che caratterizzano la sua attrattività sul piano degli investimenti infrastrutturali e produttivi e la conseguente e positiva ricaduta sul piano dell'occupazione e del benessere economico della comunità che vi risiede, migliorando nel contempo la qualità della vita e dell'ambiente.
L'Istituto di Ricerca per la Formazione-Intervento ha promosso questo convegno per discutere con amministratori pubblici, imprenditori, manager, sindacalisti, consulenti, studiosi, delle necessità che si avvertono a livello territoriale, dell'uso che si può fare della metodologia della formazione-intervento al riguardo e delle trasformazioni necessarie al sistema di regole vigenti così da consentirne l'uso.
Apertura di Renato Di Gregorio (presidente IRIFI)
L’ Istituto di Ricerca sulla Formazione – Intervento, è un istituto creato nel 1999. Lo scopo del mio intervento è quello di presentare l’Associazione, il motivo del convegno, la sua articolazione e i suoi obiettivi.
L’associazione è nata perché i soci fondatori, avendo lavorato sui processi di cambiamento che hanno attraversato l’Italia, si sono resi conto che si è di fronte ad un grande cambiamento che sta modificando l’assetto, la struttura ed il funzionamento della Pubblica Amministrazione ed il cambiamento che la Pubblica amministrazione induce a livello territoriale, anche legando nuovi accordi e relazioni con gli altri attori del territorio per lo sviluppo del territorio.
La Pubblica Amministrazione, allora, diventa una grande area di sperimentazione per coloro che si sono occupati di cambiamento, di organizzazione, di apprendimento, di formazione, di gestione del cambiamento.
Il pericolo poteva essere quello di attivare dei processi di formazione e di apprendimento dentro le imprese che si ispirassero ad un modello verticistico, tecnocratico, tayloristico, nel senso che quando c’è un cambiamento, si è soliti fare grandi campagne di formazione che coinvolgono tutte le persone di quelle organizzazioni che vengono erogate da strutture preposte per quello scopo con programmi definiti, con una progettualità anche di buon livello.
Quando si persegue questo itinerario, le persone vengono coinvolte da questi programmi, ma ne risultano attori passivi, sono coloro che devono trasformare la loro cultura, devono acquisirne una nuova. In questo caso c’è qualche progettista preparato che si mette a progettare ciò che c’è di necessità, stabilisce un programma e , poi, attraverso un funzionamento più o meno largo, riesce ad erogarlo.
Gli attori, coloro che godono di questa formazione, sono attori passivi, sono oggetto di una massa di iniziative formative che ha come obiettivo quello di cambiare la loro cultura.
Di fronte a questo fenomeno, si è preso una certa distanza e si è cercato un contesto per poter continuare ad esplorare, sperimentare, ricercare, innovare, capire ed gestire.
Gli obiettivi che i soci fondatori si sono posti sono rispondenti a due domande:
- possiamo dare una veste, una rete che ci consente di distinguere la modalità di intervento chiamandola in un altro modo e distinguendola dalle altre?
- è possibile, di fronte a questa distintività, creare consensi, esperienze, ricerche, interessi, contributi per poter continuare in questo impegno?
Si è deciso allora di creare un’associazione che fosse un po’ trasversale, che non fosse un’associazione solo di formatori, di organizzatori, di strateghi, ma fosse un’organizzazione di persone che si occupano di cambiamento, di gestione del cambiamento; da qui la nascita dell’Istituto, con sede a Roma.
Essa ha lo scopo di far ragionare le persone su queste modalità di intervento.
Lo scenario su cui collocarsi è di un grande cambiamento perché sposta a livello territoriale risorse, energie, responsabilità. C’è il bisogno di integrazione di enti diversi per cui occorre, non solo migliorare la capacità di intervento negli enti ( imprese e Pubblica amministrazione ); ma occorre migliorare la nostra capacità di intervento per far migliorare una nuova organizzazione. Essa ha delle nuove funzioni: quella di produzione, di ricerca, ha la funzione di formazione istituzionale, comunicazione, ha una serie di funzioni rappresentate dai vari enti che se ne occupano.
Il problema è di far interagire queste funzioni allo stesso modo di quando ci si è occupati di far interagire le funzioni dei Comuni, delle Province, delle imprese, delle aziende di trasporto, delle A.S.L.
Interventi come questi sono sempre più ampi perché le risorse si sono spostate a livello territoriale, nascono altre forme di organizzazione territoriale come i patti territoriali, i contratti d’area.
Tutto ciò sposta a livello territoriale risorse e responsabilità, ed allora ci si è chiesti quale poteva essere l’apporto che potevamo dare come professionisti e come persone impegnate in questi tipo di approccio.
Sono fatte sperimentazioni, riflessioni, accorgendosi che ci sono molte regole da apprendere, molte esperienze da maturare, molta ricerca ancora da fare ed alcuni sistemi di vincoli da modificare come ad esempio il sistema di erogazione delle risorse finanziarie per l’intervento su questo tipo di territorio a sostegno dei processi di intervento.
Un’altra cosa da cambiare è la modalità con cui ci si rapporta con le strutture locali e con enti che operano a livello territoriale.
Un’altra cosa da sostenere, consolidare, rappresentare, è la metodologia di intervento.
L’obiettivo di questo convegno è di rappresentare e di delineare il cambiamento in atto assieme agli attori che sono presenti sul territorio, quelli che regolano questo cambiamento. Questo è il tema del primo panel.
Il secondo panel è dedicato alle risposte che la formazione dà a questo processo di cambiamento.
Il pomeriggio è dedicato a delineare quali sono le criticità di queste risposte e quali possono essere i suggerimenti per migliorare le risposte e per consolidare alcuni processi di intervento.
Tra questi, la metodologia della formazione-intervento che punta al coinvolgimento e alla partecipazione delle persone nel processo di formazione e che differisce dalla formazione tradizionale che, invece, è costruita sull’erogazione di conoscenze alle persone, affinché coprano altri ruoli e siano attori del cambiamento.
Con la formazione – intervento le persone vengono messe in un processo di cambiamento ad assumere una responsabilità del cambiamento e, lungo la strada che loro percorrono per assumere questo nuovo ruolo, vengono offerte loro le conoscenze, le esperienze, ma soprattutto il modo per acquisire, per andarsi a ricercare le conoscenze e le esperienze per poter essere efficaci nel proprio ruolo.
L’associazione è nata perché i soci fondatori, avendo lavorato sui processi di cambiamento che hanno attraversato l’Italia, si sono resi conto che si è di fronte ad un grande cambiamento che sta modificando l’assetto, la struttura ed il funzionamento della Pubblica Amministrazione ed il cambiamento che la Pubblica amministrazione induce a livello territoriale, anche legando nuovi accordi e relazioni con gli altri attori del territorio per lo sviluppo del territorio.
La Pubblica Amministrazione, allora, diventa una grande area di sperimentazione per coloro che si sono occupati di cambiamento, di organizzazione, di apprendimento, di formazione, di gestione del cambiamento.
Il pericolo poteva essere quello di attivare dei processi di formazione e di apprendimento dentro le imprese che si ispirassero ad un modello verticistico, tecnocratico, tayloristico, nel senso che quando c’è un cambiamento, si è soliti fare grandi campagne di formazione che coinvolgono tutte le persone di quelle organizzazioni che vengono erogate da strutture preposte per quello scopo con programmi definiti, con una progettualità anche di buon livello.
Quando si persegue questo itinerario, le persone vengono coinvolte da questi programmi, ma ne risultano attori passivi, sono coloro che devono trasformare la loro cultura, devono acquisirne una nuova. In questo caso c’è qualche progettista preparato che si mette a progettare ciò che c’è di necessità, stabilisce un programma e , poi, attraverso un funzionamento più o meno largo, riesce ad erogarlo.
Gli attori, coloro che godono di questa formazione, sono attori passivi, sono oggetto di una massa di iniziative formative che ha come obiettivo quello di cambiare la loro cultura.
Di fronte a questo fenomeno, si è preso una certa distanza e si è cercato un contesto per poter continuare ad esplorare, sperimentare, ricercare, innovare, capire ed gestire.
Gli obiettivi che i soci fondatori si sono posti sono rispondenti a due domande:
- possiamo dare una veste, una rete che ci consente di distinguere la modalità di intervento chiamandola in un altro modo e distinguendola dalle altre?
- è possibile, di fronte a questa distintività, creare consensi, esperienze, ricerche, interessi, contributi per poter continuare in questo impegno?
Si è deciso allora di creare un’associazione che fosse un po’ trasversale, che non fosse un’associazione solo di formatori, di organizzatori, di strateghi, ma fosse un’organizzazione di persone che si occupano di cambiamento, di gestione del cambiamento; da qui la nascita dell’Istituto, con sede a Roma.
Essa ha lo scopo di far ragionare le persone su queste modalità di intervento.
Lo scenario su cui collocarsi è di un grande cambiamento perché sposta a livello territoriale risorse, energie, responsabilità. C’è il bisogno di integrazione di enti diversi per cui occorre, non solo migliorare la capacità di intervento negli enti ( imprese e Pubblica amministrazione ); ma occorre migliorare la nostra capacità di intervento per far migliorare una nuova organizzazione. Essa ha delle nuove funzioni: quella di produzione, di ricerca, ha la funzione di formazione istituzionale, comunicazione, ha una serie di funzioni rappresentate dai vari enti che se ne occupano.
Il problema è di far interagire queste funzioni allo stesso modo di quando ci si è occupati di far interagire le funzioni dei Comuni, delle Province, delle imprese, delle aziende di trasporto, delle A.S.L.
Interventi come questi sono sempre più ampi perché le risorse si sono spostate a livello territoriale, nascono altre forme di organizzazione territoriale come i patti territoriali, i contratti d’area.
Tutto ciò sposta a livello territoriale risorse e responsabilità, ed allora ci si è chiesti quale poteva essere l’apporto che potevamo dare come professionisti e come persone impegnate in questi tipo di approccio.
Sono fatte sperimentazioni, riflessioni, accorgendosi che ci sono molte regole da apprendere, molte esperienze da maturare, molta ricerca ancora da fare ed alcuni sistemi di vincoli da modificare come ad esempio il sistema di erogazione delle risorse finanziarie per l’intervento su questo tipo di territorio a sostegno dei processi di intervento.
Un’altra cosa da cambiare è la modalità con cui ci si rapporta con le strutture locali e con enti che operano a livello territoriale.
Un’altra cosa da sostenere, consolidare, rappresentare, è la metodologia di intervento.
L’obiettivo di questo convegno è di rappresentare e di delineare il cambiamento in atto assieme agli attori che sono presenti sul territorio, quelli che regolano questo cambiamento. Questo è il tema del primo panel.
Il secondo panel è dedicato alle risposte che la formazione dà a questo processo di cambiamento.
Il pomeriggio è dedicato a delineare quali sono le criticità di queste risposte e quali possono essere i suggerimenti per migliorare le risposte e per consolidare alcuni processi di intervento.
Tra questi, la metodologia della formazione-intervento che punta al coinvolgimento e alla partecipazione delle persone nel processo di formazione e che differisce dalla formazione tradizionale che, invece, è costruita sull’erogazione di conoscenze alle persone, affinché coprano altri ruoli e siano attori del cambiamento.
Con la formazione – intervento le persone vengono messe in un processo di cambiamento ad assumere una responsabilità del cambiamento e, lungo la strada che loro percorrono per assumere questo nuovo ruolo, vengono offerte loro le conoscenze, le esperienze, ma soprattutto il modo per acquisire, per andarsi a ricercare le conoscenze e le esperienze per poter essere efficaci nel proprio ruolo.
Intervento di Caterina Cittadino
Il cambiamento in atto è visibile e percepibile, ma poco compreso nella visione più generale, in quella che hanno gli operatori, i cittadini, in quella che hanno le persone che interagiscono perché il cambiamento in atto coinvolge, sulla base del principio della sussidiarietà, le persone, le società, gli enti pubblici, lo Stato, i cittadini, gli amministratori, tutta la società civile. Importante è comprendere lo scenario generale di tale cambiamento. L’amministrazione pubblica si sta muovendo su tre grandi scenari che nascono da varie necessità e da varie crisi della società.
Cambiare per superare le crisi è solo un aspetto! Occorre cambiare, muovendo da crisi che si sono create nell’ordinamento, per modificare, pensando al futuro.
Occorre, allora, partire dalle crisi, che è il momento dell’analisi, per comprendere perché si sono prese alcune direzioni e non altre; perché cambiare è sempre possibile, però il cambiare è frutto di scelte che vanno in una direzione in seguito ad analisi di determinate crisi.
Ma quali sono state?
Sicuramente l’atteggiamento accentratore che ha mantenuto lo Stato e che ha comportato un intervento sempre più accentrato, sempre consapevole e cosciente delle esigenze del territorio e, di conseguenza, una macchina amministrativa che è diventata sempre più complessa perché lo sviluppo della nostra società ha implicato che lo Stato si facesse carico delle esigenze della società, ma ritenesse, fino a poco tempo fa, di doverle realizzare in proprio.
Ne risulta uno Stato accentratore, uno Stato che si occupa sempre più delle esigenze che vengono dalla società e, quindi, una macchina amministrativa che, in virtù di questi due fattori concomitanti, è diventata sempre più lenta, farraginosa, incapace perché inconsapevole delle esigenze del territorio che sono diverse, perché diverso è il territorio e le esigenze della collettività che sul territorio vive ed opera, ed è incapace, poi, di essere realmente efficace.
Ma, quali sono le direzioni che sono state scelte nell’ambito dell’attuazione delle progettazioni e dell’attuazione delle riforme? Nel periodo in cui ci troviamo oggi, la fase delle grandi riforme può ritenersi conclusa al fine di dare contenuti concreti a progetti.
Cambiare la società è lo scopo della politica, per cui ogni Governo, anche in passato, si è orientato al cambiamento.
Oggi ci troviamo di fronte ad un progetto più complessivo e più difficile da attuare rispetto a qualsiasi progetto realizzato in passato. Si nota la necessità di saper sentire le esigenze del territorio, di saperle trasformare in realizzazioni, in opere. Ciò avviene attraverso un’opera di decentramento, utilizzando un principio che non compare espressamente nella nostra Costituzione, quello della “sussidiarietà” che consente di trasferire responsabilità e competenze a quegli enti che sono più vicini alla collettività, ma alla quale devono rispondere perché tale vicinanza consenta loro di conoscere, di capire meglio le esigenze della collettività e di poterle realizzare.
Cambiare per superare le crisi è solo un aspetto! Occorre cambiare, muovendo da crisi che si sono create nell’ordinamento, per modificare, pensando al futuro.
Occorre, allora, partire dalle crisi, che è il momento dell’analisi, per comprendere perché si sono prese alcune direzioni e non altre; perché cambiare è sempre possibile, però il cambiare è frutto di scelte che vanno in una direzione in seguito ad analisi di determinate crisi.
Ma quali sono state?
Sicuramente l’atteggiamento accentratore che ha mantenuto lo Stato e che ha comportato un intervento sempre più accentrato, sempre consapevole e cosciente delle esigenze del territorio e, di conseguenza, una macchina amministrativa che è diventata sempre più complessa perché lo sviluppo della nostra società ha implicato che lo Stato si facesse carico delle esigenze della società, ma ritenesse, fino a poco tempo fa, di doverle realizzare in proprio.
Ne risulta uno Stato accentratore, uno Stato che si occupa sempre più delle esigenze che vengono dalla società e, quindi, una macchina amministrativa che, in virtù di questi due fattori concomitanti, è diventata sempre più lenta, farraginosa, incapace perché inconsapevole delle esigenze del territorio che sono diverse, perché diverso è il territorio e le esigenze della collettività che sul territorio vive ed opera, ed è incapace, poi, di essere realmente efficace.
Ma, quali sono le direzioni che sono state scelte nell’ambito dell’attuazione delle progettazioni e dell’attuazione delle riforme? Nel periodo in cui ci troviamo oggi, la fase delle grandi riforme può ritenersi conclusa al fine di dare contenuti concreti a progetti.
Cambiare la società è lo scopo della politica, per cui ogni Governo, anche in passato, si è orientato al cambiamento.
Oggi ci troviamo di fronte ad un progetto più complessivo e più difficile da attuare rispetto a qualsiasi progetto realizzato in passato. Si nota la necessità di saper sentire le esigenze del territorio, di saperle trasformare in realizzazioni, in opere. Ciò avviene attraverso un’opera di decentramento, utilizzando un principio che non compare espressamente nella nostra Costituzione, quello della “sussidiarietà” che consente di trasferire responsabilità e competenze a quegli enti che sono più vicini alla collettività, ma alla quale devono rispondere perché tale vicinanza consenta loro di conoscere, di capire meglio le esigenze della collettività e di poterle realizzare.
Principio di sussidiarietà, trasferimento, attraverso un cospicuo corpo di deleghe, di tutta una serie di competenze, soprattutto operative, agli enti locali, cercando di fare attenzione ad un aspetto che è stato un altro dei problemi che in questi anni si è avuto, cioè il trasferimento diretto delle materie di competenza dello Stato alle Regioni e agli enti locali.
In passato, lo Stato accentrava, delegava poco alle Regioni, e le Regioni a loro volta, per quel poco che ricevevano, erano restie a delegare ad enti territoriali.
Oggi, sulla base del principio della pari dignità degli enti territoriali, i provvedimenti di delega consentono di considerare sia gli enti locali, ai quali si stanno delegando compiti operativi, e tutto ciò che comporta la realizzazione dei servizi, che le Regioni, alle quali si stanno delegando competenze a carattere programmatorio.
Si sta assistendo, dunque, in base al principio di sussidiarietà, ad un ribaltamento, almeno nei disegni di legge, rispetto al passato. Non bisogna, però, solo pensare al decentramento, ma è necessario pensare anche al modo in cui si realizzano i servizi.
Giannini, uno dei più grandi giuristi italiani, ha avuto il merito di trasformare il diritto amministrativo in diritto vivente, di trasformare tutto ciò che giornalmente si fa in procedimento, di capire che l’atto amministrativo è formato da una serie di azioni che si compiono quotidianamente, ha avuto il merito di rendere più vicina, più legata la teoria alla pratica.
L’amministrazione è improntata sulla base del principio della legalità, che era l’unico che consentiva di agire perché occorreva rispettare le leggi; l’unica preoccupazione del funzionario, del dirigente era che la cosa che si faceva corrispondeva alla norma che la prevedesse.
Fino a qualche anno fa, il principio della legalità è stato pensato come “fare solo ciò che la legge prevede di fare”.
In realtà, oggi, oltre al principio della legalità, sulla base delle trasformazioni in atto, ci sono i principi dell’efficacia, dell’efficienza, della economicità.
Il principio della legalità non può essere più pensato come consistente in un atto o come un’azione prevista, che sia in linea con la legge; un tale principio deve portare un risultato, deve essere, cioè, efficace ed efficiente, deve saper condurre ad un risultato che, nella scelta della soluzione e della realizzazione, deve essere più efficiente possibile. Allora il principio di legalità implica che “può farsi ciò che la legge non ti vieta di fare”. Anche in questo caso si avverte un ribaltamento, non soltanto teorico e giuridico, ma lo si riscontra nei fatti, nell’atteggiamento, nella capacità di scegliere, di decidere volta per volta qual è la cosa migliore, quale cosa può portare ad un effetto concreto.
Occorre, allora, rivedere questi meccanismi per portarli, in linea con il decentramento, ai principi di efficienza, di efficacia, che sono intervenuti in veste legislativa nel nostro ordinamento. Come? Attraverso un’opera di semplificazione, riportando al Parlamento la possibilità di svolgere la sua azione, che non è quella di definire nel dettaglio gli ordinamenti, ma di definire grandi direttive, grandi azioni perché il Parlamento deve poter esprimere ciò che è compito della politica, cioè il progresso ed il cambiamento della nostra società.
Ma come riportare nella sua sede naturale la capacità di progettare, anche sotto il profilo del procedimento e del provvedimento? Attraverso un’opera di semplificazione che si attua sulla base della delegificazione.
Vale a dire, il Parlamento si spoglia dei settori in cui è necessario che ci sia la cognizione dei tecnici, di specialisti della materia; definisce grandi principi, e la competenza primaria alla regolamentazione di questo settore compete all’amministrazione che ha il compito di realizzare, di eseguire, di fare, di trasformare le linee della legge in opere, in azioni concrete.
La delegificazione si ottiene tramite i provvedimenti, quale fonte normativa secondaria, ma che quando il Parlamento si spoglia di questa podestà, resta la fonte normativa cui bisogna far riferimento, procedimenti che sono poi realizzati attraverso la semplificazione, cioè attraverso una valutazione comparata di ciò che è giusto fare, di ciò che può essere eliminato, delimitando e seguendo soltanto quegli atti o quei provvedimenti che sono indispensabili per la realizzazione delle attività e demandano il resto alla discrezionalità.
Qui rientra il terzo grande settore, perché se il concetto dal Parlamento, attraverso la semplificazione, è passato al Governo, ed attraverso questi regolamenti di semplificazione, una grande fetta di tutto ciò che era procedimento diventa opera e quindi, discrezionalità di scelta, non si poteva non modificare il rapporto organico fra amministrazione ed i suoi operatori, dai dirigenti ai funzionari, perché impostato com’era, questa discrezionalità che oggi è indispensabile per realizzare il cambiamento, prima non era consentita.
Un rapporto di lavoro impostato sulle leggi passa alla contrattazione collettiva nazionale, quindi ad un momento pattizio in cui sindacati ed amministratori, in maniera paritaria, si confrontano per consentire la definizione dei rapporti, dei diritti e dei doveri degli impiegati e dell’amministrazione pubblica. Quindi la discrezionalità ha implicato la necessità di fornire sempre di più agli operatori, ai dirigenti, al top management dell’amministrazione pubblica, capacità e poteri dei datori di lavoro privati come realizzazione di scelta discrezionale.
La terza grande direzione è relativa al rapporto tra amministrazione e dipendenti, alla privatizzazione della dirigenza per poterla dotare di queste capacità di scelta, per attuare necessarie azioni propedeutiche per realizzare, non soltanto il rispetto per la legge, ma anche l’utilità dell’azione che sta intervenendo.
Il principio di sussidiarietà ha implicato, non soltanto la necessità di considerare alla maniera già detta per gli enti territoriali cioè Regioni, Province, Comuni, ma anche di considerare la società civile, cioè le organizzazioni che operano sul territorio che con le loro azioni promuovono il cambiamento e lo sviluppo della società.
Il principio cui si fa riferimento, introdotto nel decreto legislativo n°59 sul decentramento, è quello della sussidiarietà orizzontale che fa riferimento ad organizzazioni che operano in diverso modo e con diversi fini sul territorio.
Importante è conoscere quali sono gli interventi che lo Stato deve tenere per realizzare in proprio e quanti e quali attività può trasferire, sulla base del principio della sussidiarietà, ai privati perché da questi svolti in maniera efficiente.
Se questo è lo scenario del cambiamento, è opportuno dire che in virtù di questo disegno organico, l’attuazione di questa grande e complessa opera è molto lenta: il decentramento, per quanto riguarda il trasferimento di competenze ad enti territoriali, va molto lenta.
La semplificazione, in maniera più efficiente si sta agendo sotto il profilo della privatizzazione della dirigenza.
Sulla base dei principi della discrezionalità su cui operano e devono far riferimento i dirigenti ed i funzionari della Pubblica Amministrazione, diventa necessario un intervento massiccio ma efficace, oculato, pensato, per formare questo personale affinché possa prima comprendere, essere consapevole delle proprie possibilità, ed avere la possibilità, attraverso conoscenze ed informazioni, di realizzare effettivamente i contenuti.
Se questo meccanismo si inceppa tutto il processo di riforma. Quindi, il momento formativo, diventa un momento essenziale. Esso deve evitare gli errori di prevedere interventi che siano costanti ed uguali, ma deve prevedere forme di differenziazione a seconda della necessità. La formazione diventa il principale strumento che l’amministrazione ha a disposizione per poter procedere a questa grande opera, a questo grande progetto di cambiamento.
In passato, lo Stato accentrava, delegava poco alle Regioni, e le Regioni a loro volta, per quel poco che ricevevano, erano restie a delegare ad enti territoriali.
Oggi, sulla base del principio della pari dignità degli enti territoriali, i provvedimenti di delega consentono di considerare sia gli enti locali, ai quali si stanno delegando compiti operativi, e tutto ciò che comporta la realizzazione dei servizi, che le Regioni, alle quali si stanno delegando competenze a carattere programmatorio.
Si sta assistendo, dunque, in base al principio di sussidiarietà, ad un ribaltamento, almeno nei disegni di legge, rispetto al passato. Non bisogna, però, solo pensare al decentramento, ma è necessario pensare anche al modo in cui si realizzano i servizi.
Giannini, uno dei più grandi giuristi italiani, ha avuto il merito di trasformare il diritto amministrativo in diritto vivente, di trasformare tutto ciò che giornalmente si fa in procedimento, di capire che l’atto amministrativo è formato da una serie di azioni che si compiono quotidianamente, ha avuto il merito di rendere più vicina, più legata la teoria alla pratica.
L’amministrazione è improntata sulla base del principio della legalità, che era l’unico che consentiva di agire perché occorreva rispettare le leggi; l’unica preoccupazione del funzionario, del dirigente era che la cosa che si faceva corrispondeva alla norma che la prevedesse.
Fino a qualche anno fa, il principio della legalità è stato pensato come “fare solo ciò che la legge prevede di fare”.
In realtà, oggi, oltre al principio della legalità, sulla base delle trasformazioni in atto, ci sono i principi dell’efficacia, dell’efficienza, della economicità.
Il principio della legalità non può essere più pensato come consistente in un atto o come un’azione prevista, che sia in linea con la legge; un tale principio deve portare un risultato, deve essere, cioè, efficace ed efficiente, deve saper condurre ad un risultato che, nella scelta della soluzione e della realizzazione, deve essere più efficiente possibile. Allora il principio di legalità implica che “può farsi ciò che la legge non ti vieta di fare”. Anche in questo caso si avverte un ribaltamento, non soltanto teorico e giuridico, ma lo si riscontra nei fatti, nell’atteggiamento, nella capacità di scegliere, di decidere volta per volta qual è la cosa migliore, quale cosa può portare ad un effetto concreto.
Occorre, allora, rivedere questi meccanismi per portarli, in linea con il decentramento, ai principi di efficienza, di efficacia, che sono intervenuti in veste legislativa nel nostro ordinamento. Come? Attraverso un’opera di semplificazione, riportando al Parlamento la possibilità di svolgere la sua azione, che non è quella di definire nel dettaglio gli ordinamenti, ma di definire grandi direttive, grandi azioni perché il Parlamento deve poter esprimere ciò che è compito della politica, cioè il progresso ed il cambiamento della nostra società.
Ma come riportare nella sua sede naturale la capacità di progettare, anche sotto il profilo del procedimento e del provvedimento? Attraverso un’opera di semplificazione che si attua sulla base della delegificazione.
Vale a dire, il Parlamento si spoglia dei settori in cui è necessario che ci sia la cognizione dei tecnici, di specialisti della materia; definisce grandi principi, e la competenza primaria alla regolamentazione di questo settore compete all’amministrazione che ha il compito di realizzare, di eseguire, di fare, di trasformare le linee della legge in opere, in azioni concrete.
La delegificazione si ottiene tramite i provvedimenti, quale fonte normativa secondaria, ma che quando il Parlamento si spoglia di questa podestà, resta la fonte normativa cui bisogna far riferimento, procedimenti che sono poi realizzati attraverso la semplificazione, cioè attraverso una valutazione comparata di ciò che è giusto fare, di ciò che può essere eliminato, delimitando e seguendo soltanto quegli atti o quei provvedimenti che sono indispensabili per la realizzazione delle attività e demandano il resto alla discrezionalità.
Qui rientra il terzo grande settore, perché se il concetto dal Parlamento, attraverso la semplificazione, è passato al Governo, ed attraverso questi regolamenti di semplificazione, una grande fetta di tutto ciò che era procedimento diventa opera e quindi, discrezionalità di scelta, non si poteva non modificare il rapporto organico fra amministrazione ed i suoi operatori, dai dirigenti ai funzionari, perché impostato com’era, questa discrezionalità che oggi è indispensabile per realizzare il cambiamento, prima non era consentita.
Un rapporto di lavoro impostato sulle leggi passa alla contrattazione collettiva nazionale, quindi ad un momento pattizio in cui sindacati ed amministratori, in maniera paritaria, si confrontano per consentire la definizione dei rapporti, dei diritti e dei doveri degli impiegati e dell’amministrazione pubblica. Quindi la discrezionalità ha implicato la necessità di fornire sempre di più agli operatori, ai dirigenti, al top management dell’amministrazione pubblica, capacità e poteri dei datori di lavoro privati come realizzazione di scelta discrezionale.
La terza grande direzione è relativa al rapporto tra amministrazione e dipendenti, alla privatizzazione della dirigenza per poterla dotare di queste capacità di scelta, per attuare necessarie azioni propedeutiche per realizzare, non soltanto il rispetto per la legge, ma anche l’utilità dell’azione che sta intervenendo.
Il principio di sussidiarietà ha implicato, non soltanto la necessità di considerare alla maniera già detta per gli enti territoriali cioè Regioni, Province, Comuni, ma anche di considerare la società civile, cioè le organizzazioni che operano sul territorio che con le loro azioni promuovono il cambiamento e lo sviluppo della società.
Il principio cui si fa riferimento, introdotto nel decreto legislativo n°59 sul decentramento, è quello della sussidiarietà orizzontale che fa riferimento ad organizzazioni che operano in diverso modo e con diversi fini sul territorio.
Importante è conoscere quali sono gli interventi che lo Stato deve tenere per realizzare in proprio e quanti e quali attività può trasferire, sulla base del principio della sussidiarietà, ai privati perché da questi svolti in maniera efficiente.
Se questo è lo scenario del cambiamento, è opportuno dire che in virtù di questo disegno organico, l’attuazione di questa grande e complessa opera è molto lenta: il decentramento, per quanto riguarda il trasferimento di competenze ad enti territoriali, va molto lenta.
La semplificazione, in maniera più efficiente si sta agendo sotto il profilo della privatizzazione della dirigenza.
Sulla base dei principi della discrezionalità su cui operano e devono far riferimento i dirigenti ed i funzionari della Pubblica Amministrazione, diventa necessario un intervento massiccio ma efficace, oculato, pensato, per formare questo personale affinché possa prima comprendere, essere consapevole delle proprie possibilità, ed avere la possibilità, attraverso conoscenze ed informazioni, di realizzare effettivamente i contenuti.
Se questo meccanismo si inceppa tutto il processo di riforma. Quindi, il momento formativo, diventa un momento essenziale. Esso deve evitare gli errori di prevedere interventi che siano costanti ed uguali, ma deve prevedere forme di differenziazione a seconda della necessità. La formazione diventa il principale strumento che l’amministrazione ha a disposizione per poter procedere a questa grande opera, a questo grande progetto di cambiamento.
(Caterina Cittadino, braccio destro di Bassanini al Dipartimento della Funzione Pubblica, ente che aveva finanziato il Progetto Territorio in Sardegna. Progetto che Lei aveva seguito e controllato per poter poi, come best practice rappresentare, assieme a Renato Di Gregorio, nei capoluogo di provincia della regione Sardegna)
Intervento di Massimo Tomassini (ISFOL)
Per produrre sviluppo ed innovazione è rilevante l’esistenza di condizioni di apprendimento nelle quali gli individui, le imprese, i territori, riescano a riconoscere le proprie identità e a creare circuiti di produzione e circolazione delle conoscenze di tipo virtuoso.
L’economia dell’apprendimento è importante per almeno quattro fattori tra loro strettamente intrecciati
Il primo fattore è relativo alle tecnologie dell’informazione, perché siamo in un contesto di sviluppo in cui le tecnologie dell’informazione facilitano le opportunità di apprendimento a tutti i livelli, dall’apprendimento degli individui all’apprendimento di processi nel campo della chimica che si possono desumere andando su certi siti e dialogando con esperti.
Il secondo fattore dello sviluppo dell’apprendimento è relativo alla nuova geografia economica globale del mondo perché lo sviluppo, ormai, avviene a livello di territori che sono in grado di assicurare attrattività di investimenti e condizioni opportune per lo sviluppo produttivo grazie alla disponibilità di risorse fisiche ed immateriali. La logica a matriosca, in cui ci sono una serie di contenitori, che sono gli stati nazionali, dentro cui ci sono altre piccole bamboline, che corrispondono ai territori sempre più circoscritti, non è più presa in considerazione perché all’immagine della matriosca si deve sostituire quella del mosaico dove si hanno territori in cui lo sviluppo si fa perché funzionano quei fattori di sviluppo e di attrattività degli investimenti, di valorizzazione delle risorse e territori del mosaico in cui questa virtuosità del circuito conoscenze – investimenti non è stata innescata.
Il terzo fattore fondamentale è dato dal fatto che sono cambiate le strutture della produzione perché il nostro è un mondo dominato da forme di produzione flessibile in quei territori che funzionano meglio e che consentono la riarticolazione delle strutture dei processi produttivi su scala locale con la creazione di reti che sono decentramenti di grandi imprese o sono indifferentemente reti di piccole e medie imprese capaci di collaborare con loro e di , attraverso il loro apprendimento reciproco, sviluppare le conoscenze necessarie.
Il quarto fattore è relativo alle conoscenze in quanto tali, quelle che fanno l’economia della conoscenza, dell’apprendimento e che si sedimentano in competenze e in capacità di agire programmi di azione adeguati a determinati contesti e di implementare conoscenze a diversi livelli che riescono a creare vantaggi competitivi. C’è un forte nesso tra competenze individuali e competenze di successo delle imprese perché ci sono esperti che creano vantaggio competitivo per le imprese che spesso viene taciuto quando si parla di metacompetenze, di competenze trasversali per lo sviluppo della conoscenza.
Questo è il campo in cui si pone il problema dello sviluppo della formazione per lo sviluppo territoriale; è evidente che il ruolo essenziale della formazione in questo contesto, è quello di sostenere la particolare risorsa conoscenza incorporata in competenze che è la risorsa vincente per vincere la sfida competitiva e per partecipare ciascun territorio a quell’economia mondiale in cui diversi territori si confrontano, vincono o perdono a seconda del fatto che abbiano maggiori o minori capacità di sviluppare le risorse e le competenze.
Dal punto di vista dei sistemi informativi, è necessario incrementare modelli formativi non imitati ai cicli tradizionali, ma articolati in funzione di esigenze quali: la formazione continua, l’apprendimento nel corso della vita da parte di vari soggetti.
Il secondo aspetto riguarda le diverse agenzie formative che devono sviluppare la cooperazione tra di loro assumendo come obiettivo comune lo sviluppo delle competenze su scala locale; è necessario intensificare le interazioni, l’apprendimento reciproco non solo delle istituzioni formative tra loro, ma anche delle istituzioni formative rispetto alle amministrazioni pubbliche, alle strutture che garantiscono lo sviluppo. È necessario riconoscere l’impresa come luogo di apprendimento in cui i processi produttivi sono anche processi di creazione di conoscenze, di valorizzazione, di creazione di competenze. Il sistema formativo educativo, nelle sue varie articolazioni: formazione professionale, la scuola, l’Università, dovrebbe sentirsi, nell’insieme, coinvolto nello sviluppo del contesto territoriale. Ciò significa innovare queste istituzioni educative – formative.
Allora, la formazione – intervento, come modalità per lo sviluppo dell’apprendimento, ha un ruolo essenziale da giocare, un ruolo di sviluppo delle medesime istituzioni che sarebbe opportuno far partecipare ad iniziative di formazione – intervento, applicare la formazione – intervento alla scuola, alla formazione professionale, all’Università.
Sotto il termine della formazione – intervento, convergono quelle prospettive sia teoriche, sia di azione, anche piuttosto diverse tra loro che comprende quella sviluppata in Inghilterra e che ricerca e formazione attraverso la ricerca e quella in cui il problema è di trovare soluzioni specifiche per determinati contesti.
È opportuno pertanto discutere sulla fattibilità di azioni di formazione – intervento a livello territoriale in risposta ai problemi e alle aspettative tra diversi attori sociali.
L’economia dell’apprendimento è importante per almeno quattro fattori tra loro strettamente intrecciati
Il primo fattore è relativo alle tecnologie dell’informazione, perché siamo in un contesto di sviluppo in cui le tecnologie dell’informazione facilitano le opportunità di apprendimento a tutti i livelli, dall’apprendimento degli individui all’apprendimento di processi nel campo della chimica che si possono desumere andando su certi siti e dialogando con esperti.
Il secondo fattore dello sviluppo dell’apprendimento è relativo alla nuova geografia economica globale del mondo perché lo sviluppo, ormai, avviene a livello di territori che sono in grado di assicurare attrattività di investimenti e condizioni opportune per lo sviluppo produttivo grazie alla disponibilità di risorse fisiche ed immateriali. La logica a matriosca, in cui ci sono una serie di contenitori, che sono gli stati nazionali, dentro cui ci sono altre piccole bamboline, che corrispondono ai territori sempre più circoscritti, non è più presa in considerazione perché all’immagine della matriosca si deve sostituire quella del mosaico dove si hanno territori in cui lo sviluppo si fa perché funzionano quei fattori di sviluppo e di attrattività degli investimenti, di valorizzazione delle risorse e territori del mosaico in cui questa virtuosità del circuito conoscenze – investimenti non è stata innescata.
Il terzo fattore fondamentale è dato dal fatto che sono cambiate le strutture della produzione perché il nostro è un mondo dominato da forme di produzione flessibile in quei territori che funzionano meglio e che consentono la riarticolazione delle strutture dei processi produttivi su scala locale con la creazione di reti che sono decentramenti di grandi imprese o sono indifferentemente reti di piccole e medie imprese capaci di collaborare con loro e di , attraverso il loro apprendimento reciproco, sviluppare le conoscenze necessarie.
Il quarto fattore è relativo alle conoscenze in quanto tali, quelle che fanno l’economia della conoscenza, dell’apprendimento e che si sedimentano in competenze e in capacità di agire programmi di azione adeguati a determinati contesti e di implementare conoscenze a diversi livelli che riescono a creare vantaggi competitivi. C’è un forte nesso tra competenze individuali e competenze di successo delle imprese perché ci sono esperti che creano vantaggio competitivo per le imprese che spesso viene taciuto quando si parla di metacompetenze, di competenze trasversali per lo sviluppo della conoscenza.
Questo è il campo in cui si pone il problema dello sviluppo della formazione per lo sviluppo territoriale; è evidente che il ruolo essenziale della formazione in questo contesto, è quello di sostenere la particolare risorsa conoscenza incorporata in competenze che è la risorsa vincente per vincere la sfida competitiva e per partecipare ciascun territorio a quell’economia mondiale in cui diversi territori si confrontano, vincono o perdono a seconda del fatto che abbiano maggiori o minori capacità di sviluppare le risorse e le competenze.
Dal punto di vista dei sistemi informativi, è necessario incrementare modelli formativi non imitati ai cicli tradizionali, ma articolati in funzione di esigenze quali: la formazione continua, l’apprendimento nel corso della vita da parte di vari soggetti.
Il secondo aspetto riguarda le diverse agenzie formative che devono sviluppare la cooperazione tra di loro assumendo come obiettivo comune lo sviluppo delle competenze su scala locale; è necessario intensificare le interazioni, l’apprendimento reciproco non solo delle istituzioni formative tra loro, ma anche delle istituzioni formative rispetto alle amministrazioni pubbliche, alle strutture che garantiscono lo sviluppo. È necessario riconoscere l’impresa come luogo di apprendimento in cui i processi produttivi sono anche processi di creazione di conoscenze, di valorizzazione, di creazione di competenze. Il sistema formativo educativo, nelle sue varie articolazioni: formazione professionale, la scuola, l’Università, dovrebbe sentirsi, nell’insieme, coinvolto nello sviluppo del contesto territoriale. Ciò significa innovare queste istituzioni educative – formative.
Allora, la formazione – intervento, come modalità per lo sviluppo dell’apprendimento, ha un ruolo essenziale da giocare, un ruolo di sviluppo delle medesime istituzioni che sarebbe opportuno far partecipare ad iniziative di formazione – intervento, applicare la formazione – intervento alla scuola, alla formazione professionale, all’Università.
Sotto il termine della formazione – intervento, convergono quelle prospettive sia teoriche, sia di azione, anche piuttosto diverse tra loro che comprende quella sviluppata in Inghilterra e che ricerca e formazione attraverso la ricerca e quella in cui il problema è di trovare soluzioni specifiche per determinati contesti.
È opportuno pertanto discutere sulla fattibilità di azioni di formazione – intervento a livello territoriale in risposta ai problemi e alle aspettative tra diversi attori sociali.
(Massimo Tomassini, un profondo conoscitore e studioso di apprendimento, cofondatore di IRIFI. E' lui che ci ha convinto tutti che dovevamo chiamare "Istituto" e non "Associazione" ciò che abbiamo, tutti assieme, costituito il 30 marzo del 1999, nel suo appartamento in affitto a Piazza in Piscinula, a Trastevere. Appartamento che ha ospitato Renato Di Gregorio e molte delle attività condotte nei primi anni del 2000, compresa la nascita delle Associazioni di Comuni del Lazio:)
Intervento di Bepi Tomai (amministratore delegato del Formez)
Ci sono tre stagioni che ricordano il legame tra formazione e territorio.
La prima stagione è relativa agli anni 50 in cui sono state fatte esperienze di formazione legate al territorio in una visione comunitaristica dove la formazione per la maggior parte dei cittadini si giudicava alfabetizzazione perché il problema era la lotta all’analfabetismo.
La seconda stagione è quella degli anni 70 in cui si è riscoperto da altro punto di vista il territorio e il suo sviluppo; vi era la convinzione potesse liberare delle energie creando delle competenze perché alcuni aspetti dello sviluppo locale sono frenati dalla mancanza di tali competenze a livello locale, per cui è opportuna una formazione per aiutare a leggere le risorse del territorio e formare delle competenze senza delle quali le risorse non diventano posto di lavoro, sviluppo, occupazione, reddito, valore aggiunto.
La terza stagione è relativa agli anni 90 in cui si è prestata più attenzione al legame tra formazione e sviluppo territoriale.
Lo sviluppo locale, oggi, richiede che si faccia ricorso ai tre fattori menzionati perché ha bisogno di soggetti che siano i protagonisti del loro territorio, ha bisogno di competenze per la realizzazione di un progetto di sviluppo, ha bisogno di dare attenzione alla globalizzazione.
La formazione si può muovere su alcuni fronti:
- occorre rivedere a livello di sistema la formazione della dimensione locale,
- occorre rivolgersi a quegli interventi volti a rafforzare e a sviluppare nuove competenze per accompagnare processi locali di sviluppo.
La formazione – intervento è una leva importante per le situazioni che si vanno generando a livello territoriale in cui si sta dando più attenzione allo sviluppo locale e alle risorse umane dello sviluppo locale.
La prima stagione è relativa agli anni 50 in cui sono state fatte esperienze di formazione legate al territorio in una visione comunitaristica dove la formazione per la maggior parte dei cittadini si giudicava alfabetizzazione perché il problema era la lotta all’analfabetismo.
La seconda stagione è quella degli anni 70 in cui si è riscoperto da altro punto di vista il territorio e il suo sviluppo; vi era la convinzione potesse liberare delle energie creando delle competenze perché alcuni aspetti dello sviluppo locale sono frenati dalla mancanza di tali competenze a livello locale, per cui è opportuna una formazione per aiutare a leggere le risorse del territorio e formare delle competenze senza delle quali le risorse non diventano posto di lavoro, sviluppo, occupazione, reddito, valore aggiunto.
La terza stagione è relativa agli anni 90 in cui si è prestata più attenzione al legame tra formazione e sviluppo territoriale.
Lo sviluppo locale, oggi, richiede che si faccia ricorso ai tre fattori menzionati perché ha bisogno di soggetti che siano i protagonisti del loro territorio, ha bisogno di competenze per la realizzazione di un progetto di sviluppo, ha bisogno di dare attenzione alla globalizzazione.
La formazione si può muovere su alcuni fronti:
- occorre rivedere a livello di sistema la formazione della dimensione locale,
- occorre rivolgersi a quegli interventi volti a rafforzare e a sviluppare nuove competenze per accompagnare processi locali di sviluppo.
La formazione – intervento è una leva importante per le situazioni che si vanno generando a livello territoriale in cui si sta dando più attenzione allo sviluppo locale e alle risorse umane dello sviluppo locale.
Dimensione: 148,17 KB
Mauro Frongia, un esperto di Formazione professionale con il quale abbiamo realizzato il programma di formazione-Intervento per esperti di project management a Treviso. Tra le istituzioni che hanno ospitato i partecipanti nel loro lavoro di progettazione partecipata c'era anche la Provincia di Treviso, dove allora c'era il Presidente: Luca Zaia. Nel suo intervento che accludiamo c'è un prezioso suggerimento di come modificare il sistema di finanziamento alla formazione considerando la differenza tra la formazione tradizionale e la formazione-intervento. Intervento di Luca Zaia (all'epoca presidente della Provincia di Treviso)
La Provincia di Treviso ha delle prerogative uniche: conta 760.000 abitanti, ha un imprenditore ogni 7 abitanti, fa formazione in proprio da più di 50 anni.
La formazione di primo livello che fa, non risponde esilmente alle richieste del territorio; i corsi durano tre anni con la possibilità di recuperare una fascia della popolazione che altrimenti non studierebbero negli anni della obbligatorietà.
Il Governo, però, non riconosce l’obbligatorietà scolastica ai centri di formazione professionale.
Il Fondo Sociale Europeo in Italia funziona poco perché si fanno più di seicento corsi di formazione sociale europea in Provincia di Treviso, dove il 70% dei quali non ha nessun impatto sul mercato!
Da ciò emerge che non c’è programmazione, ovvero l’incontro tra la domanda e l’offerta e un utopia sia sul settore formativo, sia sul settore del mercato del lavoro.
C’è sicuramente la necessità di lavorare sul primo livello formativo, ma è opportuno investire anche sul secondo livello formativo che risponde alle esigenze del mercato. Ma ancora non si è pronti perché la Provincia richiede deleghe certe alla Regione Veneto, deleghe che la Regione ancora non dà e che deve ancora applicare dotazioni legislative minimali come la legge Bassanini che permettono di dare risposte al territorio.
(Luca Zaia, avendo apprezzato l'intervento ha poi chiamato Renato Di Gregorio a seguire due progetti importanti: la riorganizzazione dei Centri dell'impiego e la Comunicazione della Provincia di Treviso, entrambi realizzati con la metodologia della Formazione-Intervento).
La formazione di primo livello che fa, non risponde esilmente alle richieste del territorio; i corsi durano tre anni con la possibilità di recuperare una fascia della popolazione che altrimenti non studierebbero negli anni della obbligatorietà.
Il Governo, però, non riconosce l’obbligatorietà scolastica ai centri di formazione professionale.
Il Fondo Sociale Europeo in Italia funziona poco perché si fanno più di seicento corsi di formazione sociale europea in Provincia di Treviso, dove il 70% dei quali non ha nessun impatto sul mercato!
Da ciò emerge che non c’è programmazione, ovvero l’incontro tra la domanda e l’offerta e un utopia sia sul settore formativo, sia sul settore del mercato del lavoro.
C’è sicuramente la necessità di lavorare sul primo livello formativo, ma è opportuno investire anche sul secondo livello formativo che risponde alle esigenze del mercato. Ma ancora non si è pronti perché la Provincia richiede deleghe certe alla Regione Veneto, deleghe che la Regione ancora non dà e che deve ancora applicare dotazioni legislative minimali come la legge Bassanini che permettono di dare risposte al territorio.
(Luca Zaia, avendo apprezzato l'intervento ha poi chiamato Renato Di Gregorio a seguire due progetti importanti: la riorganizzazione dei Centri dell'impiego e la Comunicazione della Provincia di Treviso, entrambi realizzati con la metodologia della Formazione-Intervento).
Intervento di Costantino Formica
Se i fondi strutturali, se le Regioni sono ingabbiate da una riforma pur valida e positiva, ma che non raccolgono impulsi che vengono dalla società civile, che non sanno coniugare il cambiamento organizzativo, il cambiamento per innovare, per affermare principi anche ordinamentali di innovazione ma anche di miglior utilizzo delle risorse, non si può guardare più semplicemente alla formazione tradizionale, ma bisogna pensare in grande, in modo da consentire agli attori che fino ad oggi sono stati chiamati utenti, allievi, al massimo partecipanti, di guardare loro con un occhio da protagonisti, come soggetti di avvio di capacità di processi di cambiamento.
Ciò sta avvenendo per la realizzazione dello Sportello Unico per le attività produttive nell’area del brindisino dove gli operatori, i dipendenti pubblici si stanno misurando con il cambiamento, con l’introduzione di un nuovo processo complesso ma necessario, avvertito come una delle riforme principali degli ultimi anni, che non vede più l’erogazione della formazione come strumento unicamente per l’acquisizione di nuove conoscenze, ma che cerca di coinvolgere il dipendente nell’apprendimento complessivo organizzativo e nel trasformarlo in protagonista di implementazioni di strutture organizzative del tutto nuove.
Altro elemento innovativo è la programmazione negoziale che in Italia ha avuto un impulso fondamentale ed ha promosso un processo culturale ed innovativo che veniva dalla Comunità Europea. Nella prima fase della programmazione negoziale, è avvenuto un processo straordinario: la concertazione che ha portato gli attori del territorio a riunirsi attorno ad un tavolo, quelli fino ad ora dimenticati dallo Stato, quelli ai quali fino ad ora non era mai stata data un’offerta reale di protagonismo, quelli che dovevano essere gli stessi soggetti che potevano decidere le politiche di sviluppo, innovando rispetto al passato, che era improntato sostanzialmente sulla filosofia dell’accentramento delle decisioni che non corrispondevano alla logica di sviluppo individuato sul piano oggettivo.
In questo processo di definizione di sviluppo del territorio erano esclusi i sindaci, i responsabili della sanità, le organizzazioni culturali del territorio, il sistema scolastico, le Università, le organizzazioni sindacali.
Con la programmazione negoziale si è puntati sul decentramento delle decisioni, sulla responsabilizzazione continua, sul principio della sussidiarietà, sul fatto che un Sindaco è in grado di mettere a punto una strategia di sviluppo che va costruita, gestita, progettata, realizzata d’accordo con altri sindaci concertando i propri interessi di sviluppo territoriale con quelli di un altro territorio confinante.
Tale processo di concertazione comporta l’apprendimento e la gestione di sviluppo del territorio.
Ciò sta avvenendo per la realizzazione dello Sportello Unico per le attività produttive nell’area del brindisino dove gli operatori, i dipendenti pubblici si stanno misurando con il cambiamento, con l’introduzione di un nuovo processo complesso ma necessario, avvertito come una delle riforme principali degli ultimi anni, che non vede più l’erogazione della formazione come strumento unicamente per l’acquisizione di nuove conoscenze, ma che cerca di coinvolgere il dipendente nell’apprendimento complessivo organizzativo e nel trasformarlo in protagonista di implementazioni di strutture organizzative del tutto nuove.
Altro elemento innovativo è la programmazione negoziale che in Italia ha avuto un impulso fondamentale ed ha promosso un processo culturale ed innovativo che veniva dalla Comunità Europea. Nella prima fase della programmazione negoziale, è avvenuto un processo straordinario: la concertazione che ha portato gli attori del territorio a riunirsi attorno ad un tavolo, quelli fino ad ora dimenticati dallo Stato, quelli ai quali fino ad ora non era mai stata data un’offerta reale di protagonismo, quelli che dovevano essere gli stessi soggetti che potevano decidere le politiche di sviluppo, innovando rispetto al passato, che era improntato sostanzialmente sulla filosofia dell’accentramento delle decisioni che non corrispondevano alla logica di sviluppo individuato sul piano oggettivo.
In questo processo di definizione di sviluppo del territorio erano esclusi i sindaci, i responsabili della sanità, le organizzazioni culturali del territorio, il sistema scolastico, le Università, le organizzazioni sindacali.
Con la programmazione negoziale si è puntati sul decentramento delle decisioni, sulla responsabilizzazione continua, sul principio della sussidiarietà, sul fatto che un Sindaco è in grado di mettere a punto una strategia di sviluppo che va costruita, gestita, progettata, realizzata d’accordo con altri sindaci concertando i propri interessi di sviluppo territoriale con quelli di un altro territorio confinante.
Tale processo di concertazione comporta l’apprendimento e la gestione di sviluppo del territorio.
(Costantino Formica compagno di vita, di studio e di lavoro di Renato Di Gregorio dal 1966, Deputato della Repubblica e cofondatore dell'IRIFI).
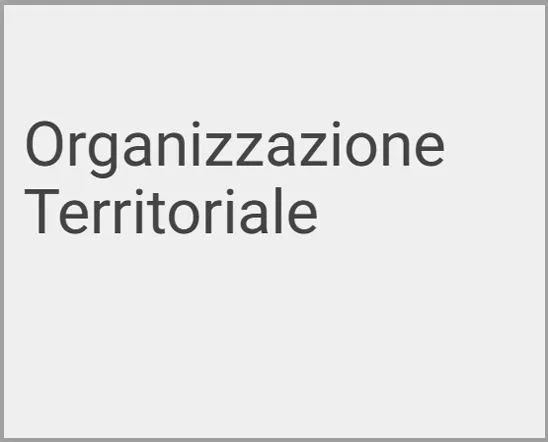




 Locandina del Convegno
Locandina del Convegno